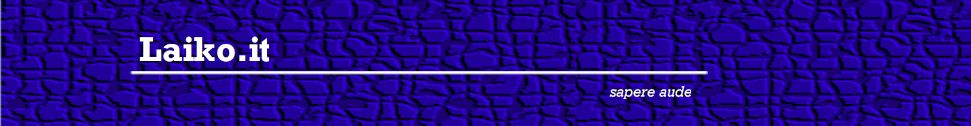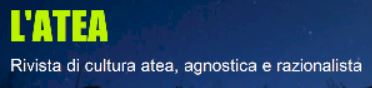Corpi senz’anima e morti sospese.
Quando si muore? come si muore? che cosa effettivamente muore? La religione avrebbe (ed aveva, certamente, un tempo) risposte nette quali: ‘la morte è la separazione dell’anima dal corpo’. Ma quando e come l’anima si separerebbe dal corpo, determinando la morte?
Comunque lo si voglia intendere, i cristiani presuppongono alla fine della vita un diverso destino di queste due entità, il cui rapporto è tuttaltro che definito. Magistero e catechesi rispondono in maniera assolutamente contraddittoria su cosa avverrebbe effettivamente: è il corpo che cessa di funzionare lasciando libera l’anima? o è l’anima che abbandona il corpo quando questo non può più sostenerne l’attività, sicché ‘dopo’ il corpo muore? In sostanza, nell’evento morte, c’è un momento in cui l’anima è ancora unita ad un corpo già morto o c’è un momento in cui il corpo ha ancora delle funzionalità ‘vitali’ pur se l’anima s’è già separata? L’etica della morte sospesa gravita sostanzialmente su tale questione.
Fin dai primi anni del Novecento era nota la possibilità di prolungare artificialmente per un breve periodo alcune funzioni vitali in soggetti altrimenti definibili come morti, ed era stata avanzata l’idea che la morte cerebrale potesse significare da sola la morte dell’individuo.
Tale discussione poteva ben dirsi ‘accademica’ e non suscitava l’interesse dei teologi, in quanto la pratica medica non contemplava né sopravvivenze in ‘stato vegetativo’ né problemi di espianto d’organi vitali. Ma le cose cambiarono drasticamente dopo i primi trapianti cardiaci, aspramente contestati sia dai religiosi che da una ristretta parte del mondo medico. Si manifestò infatti una remora morale di fondo per il tipo di intervento in sé, che avrebbe violato l’integrità ‘sacra’ dell’individuo; ma è indubbio che le condizioni in cui in effetti avvennero i primi trapianti cardiaci soddisferebbero anche i criteri attualmente richiesti.
Pochi mesi dopo, il ‘rapporto Harvard’, che mise un punto fermo alla questione, propose definitivamente la morte cerebrale come vera morte dell’individuo. Dunque, chiaramente, secondo le scienze mediche, l’individuo (la mente; l’Io razionale e cosciente) poteva essere fatto coincidere con una sola parte del suo sistema nervoso.
Ma tale criterio ha trovato agguerriti avversari, che basano le loro critiche principalmente sul fatto che molte parti del corpo continuano a ‘funzionare’ come prima anche dopo la ‘morte cerebrale’, talora perfino per anni (come nel caso dello stato vegetativo persistente’), in quanto la funzione ‘integrativa’ di alcune aree encefaliche (non legate alla coscienza) viene comunque in qualche modo mantenuta.
Col passare degli anni, si è inoltre reso evidente che non si può parlare tout court di morte cerebrale, giacché in molti casi la morte della ‘corteccia’ non si accompagna alla morte del tronco encefalico. In sostanza, non tutto il sistema nervoso supporta l’individualità cosciente, ma solo un parte di esso; mentre invece, in questi pazienti, il midollo spinale continua a funzionare ed a svolgere la sua attività integrativa ‘periferica’ pur in assenza di un controllo centrale.
I successi della medicina più recente hanno consentito perfino l’emergere di una vera e propria condizione di morte sospesa, diversa dalla morte cerebrale ma anche dallo stato cosiddetto di ‘coscienza minima’; un qualcosa che non esiste in natura e che nessun teologo fino ad alcuni decenni orsono avrebbe potuto prevedere: lo stato vegetativo persistente. La possibilità che soggetti in tale condizione (quando correttamente diagnosticata) vadano incontro, anche dopo molti anni, ad un sia pur minimo recupero della coscienza, sembra più una credenza dei familiari e dei media che un riscontro oggettivo. Questi soggetti non recupereranno mai (salvo i rari casi di errata diagnosi) uno stato di coscienza migliore di quello superstite, generalmente nullo; sono corpi senza mente. Le loro uniche manifestazioni motorie evidenziabili sono semplici attività riflesse, al puro livello biologico, e non già indizi di una qualche attività della ‘persona’. Sono di fatto dei morti viventi, nei quali il cristiano dovrebbe riconoscere come già scisso il legame anima-corpo.
Di fronte ad un paziente del quale non è ipotizzabile, con ragionevole certezza, alcun recupero della coscienza, è possibile continuare a sottoporlo a cure ‘ordinarie’ palliative, ma possono essere anche applicate due strategie ‘mediche’ di segno totalmente opposto: l’accanimento terapeutico e la desistenza terapeutica.
Per ‘accanimento terapeutico’ si intende l’atteggiamento pratico di quei medici che ritengono proprio dovere prolungare il più possibile il funzionamento dell'organismo del paziente, in qualunque condizione ciò avvenga, relegando in secondo piano le considerazioni su ogni altra dimensione della vita umana che non sia quella biologica.
Per ‘desistenza terapeutica’ si intende invece la rinuncia ad un trattamento giudicato inutile, e in molti casi disumanizzante, consentendo che l’evento del morire si compia nei modi e nei tempi naturali.
Molti teologi, in un passato recente, hanno ritenuto la desistenza assolutamente legittima, moralmente accettabile, ed in linea con il rispetto della dignità umana. Ciò rifletteva un atteggiamento clericale piuttosto critico verso la disumanizzazione della medicina indotta dal ‘tecnicismo’. Ma oggi, paradossalmente, è proprio il clero ad invocare questo tecnicismo (sia pure definendolo, ipocritamente, semplice ‘assistenza ordinaria’); mentre la classe medica appare sempre più favorevole alle pratiche cosiddette di ‘eutanasia passiva’. E perfino l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1978, ha invitato i medici a non violare il ‘diritto di morire’ che appartiene ad ogni uomo.
Entriamo così nella problematica dell’eutanasia nei soggetti in stato di morte sospesa, da affrontare in modo diverso rispetto a quello dell’eutanasia in generale, che riguarda una gamma diversa di situazioni cliniche ed umane.
Nel nostro caso si tratta di individui che hanno certamente perduto ciò che costituiva il proprio ‘essere uomo’ (il pensiero, la coscienza, la volontà) ed il cui solo corpo continua in qualche modo a funzionare se gli viene fornito un continuo ed adeguato supporto medico-assistenziale.
La morale comune non ha difficoltà a considerare questi individui formalmente morti, se è vero che il 60% degli italiani è favorevole a pratiche di eutanasia passiva e che un numero crescente di anestesisti e rianimatori ammettono di avervi fatto ricorso o addirittura di avere somministrato farmaci letali.
In una visione più ampia, questa problematica è legata a quella del consenso informato agli atti medici. In quasi tutti i paesi europei la legislazione riconosce infatti il diritto soggettivo del malato a rifiutare trattamenti medici e chirurgici anche quando tale rifiuto comporti la morte.
Il Magistero cattolico invece, ovviamente, non accetta tale principio, sulla base del fatto che il quinto comandamento ‘non uccidere’ è stato sempre interpretato, estensivamente, come obbligo di provvedere alla propria vita ed alla propria salute; anche se ciò, almeno tradizionalmente, solo fin tanto che si resta nell’ambito delle cure ‘ordinarie’.
Se, invece, le cure mediche o chirurgiche assumono carattere di straordinarietà, il giudizio morale può cambiare. E fra gli autori moderni, il sempre citato Pio XII aveva ad esempio ribadito a tal proposito,: ‘Nessuno è moralmente obbligato a curarsi con terapie straordinarie’, intendendo come ‘straordinarie’ le terapie caratterizzate da rischio, rarità, dolorosità o costo.
Dopo di lui, la Sacra congregazione per la Dottrina della fede (‘Dichiarazione sull’eutanasia’) aveva precisato che in tali casi ‘il rifiuto non equivale al suicidio; significa, piuttosto, accettazione della condizione umana’.
Nel caso dei soggetti in stato vegetativo persistente il problema assume una rilevanza etica maggiore, in quanto trattasi di una decisione che riguarda altri e non se stessi. In tal caso l’elemento base su cui porre il giudizio è lo stato clinico del paziente, ed in particolare se sia possibile un qualche ricupero delle sue facoltà intellettive.
L’attuale Catechismo non lascia alcuno spazio alla possibilità di sospendere il supporto vitale nei soggetti in Stato vegetativo persistente. È anche vero che nell’Enciclica 'Evangelium vitae' del 1995 Giovanni Paolo II ha sostenuto che è lecito sospendere l’applicazione delle cure quando i risultati non rispondono all’aspettativa, e che in tale decisione bisogna tener conto del giusto desiderio del malato e dei suoi cari; ma, come in tanti altri casi, le sue affermazioni hanno consentito letture di segno opposto. Se infatti si parte dal presupposto che alimentazione ed idratazione artificiale non sono per nulla ‘cure mediche’ ma solo ‘assistenza di base’, ne deriva che in nessun caso si può abbandonare il malato alla sua sorte, e dunque, ancora una volta, il solo criterio di morte accettabile dalla chiesa resta la cessazione delle funzioni cardiaca e respiratoria, mentre la cessazione della funzione cerebrale risulta assolutamente ininfluente.
Le decisioni di fine vita nei confronti di pazienti in Stato Vegetativo Persistente sono indubbiamente delicate e controverse. Non si tratta di decidere solo dello status di un corpo senza evidente vita ‘umana’, ma di prendere atto dei vari contesti medico, sociale ed etico, che forzano in direzioni contrarie.
Per la scienza, costoro non possono più recuperare alcunché. La chiesa sembra invece divisa fra pietas (legittima) e speranza (sottaciuta). La teologia fra l’altro non può negare la asserita possibilità teorica del miracolo di un ‘risveglio’, che però non dichiara mai di aspettarsi. Giacché dunque dallo Stato Vegetativo Persistente non si esce, possiamo chiederci: esiste, secondo la teologia, un interesse soggettivo del paziente in SVP a che si prolunghi il suo stato di morte sospesa?
Su questi punti il magistero cattolico si è sempre dimostrato incerto e contraddittorio. Clero e bioeticisti hanno ulteriormente complicato il giudizio, basandosi ora su questo ora su quell’altro presupposto teologico.
Affermando l’universalità del precetto secondo il quale ‘la vita umana è sacra’, la chiesa cattolica fa riferimento a ciò che chiunque può ordinariamente intendere per vita (movimento, psichismo, etc…), chiaramente distinto da ciò che non lo è. Ma la gamma delle situazioni concrete, in conseguenza dell’intervento medico, è attualmente variegata e ad esse non si può applicare rigidamente una distinzione basata su di un criterio che ha perso gran parte del suo valore classificativo.
I teologi ed i bio-eticisti di formazione cattolica rimproverano alla medicina di frontiera di avere rinnegato i tradizionali riferimenti religiosi e sapienziali; ma non poteva accadere diversamente.
I concetti teologici tradizionali, sui quali si basavano i giudizi morali in questioni come le decisioni sulla vita, sono infatti chiaramente inadeguati a risolvere le problematiche attualmente originate dai progressi medici.
Per difendere astrattamente la vita, la chiesa cattolica difende tutto ciò che ha una minima parvenza di vita. Ma la società deve liberarsi da questi pregiudizi; ed i credenti non possono imporre a tutti le proprie illusioni e le proprie disperate speranze.