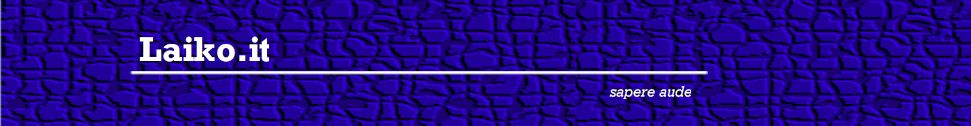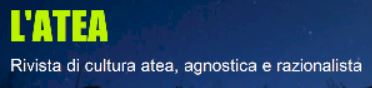Editoriale
[L’ATEO, 4/2018]
di Francesco D’Alpa
«Lo stomaco è il maestro di musica che infrena e sprona la grande orchestra delle grandi passioni; lo stomaco vuoto suona il fagotto del livore e il flauto dell’invidia; lo stomaco pieno batte il sistro del piacere e il tamburo della gioia» (Gioachino Rossini)
L’alimentazione è al centro della vita, ed ogni civiltà ha sue specifiche tradizioni nelle quali possiamo riconoscere varie esigenze e finalità, ciascuna delle quali condiziona la scelta degli alimenti, ovvero i vari regimi dietetici: fra questi, quello ‘fisiologico’ (onnivoro o vegetariano) mira a preservare la salute, con scelte corrette; quello terapeutico si propone di aiutare una guarigione o di ristabilire una condizione ideale. Più importante, nella nostra società attuale, che tende sempre più all’abolizione di ogni tradizione e regola, è comunque la finalità edonistica, che sottopone tutto al gusto ed alla sazietà. Ma in questo numero dell’ATEO vogliamo in particolare occuparci del complesso legame, spesso lontano dalla razionalità dei regimi fisiologici e terapeutici, fra alimentazione e religione.
Il più arcaico fra i suoi caratteri è una lontana eredità culturale: l’idea che il cibo sia un dono di divinità che per questo vanno ringraziate, con offerte e sacrifici, sacralizzando il pasto. Così nell’ebraismo e poi nel cristianesimo, non a caso, il giardino dell’Eden è la raffigurazione immaginaria del passato di un popolo di cacciatori-raccoglitori beneficiati da un dio magnanimo; i suoi simbolismi religiosi sono invariabilmente legati al mondo vegetale e contadino, ed alcuni usi sono perseverati a lungo (benedire il pane, segnarlo con la croce, suddividerlo in parti ben precise, ungere l’aratro con l’olio prima di iniziare i lavori agricoli, invocare i santi protettori dei raccolti). Secondo l’ebraismo, dopo il dramma del peccato originale, il cibo santifica il lavoro umano; si prega per ottenerlo; lo si offre a Dio; funge da elemento di mediazione fra i vivi e i morti nei riti funerari (alcuni di questi aspetti sono comuni con altre religioni). Tutte (in particolare cristianesimo, islam, ebraismo, induismo) hanno dettato (alcune lo fanno fortemente tuttora) precise norme circa il modo di produrre, trattare, cucinare e assumere i cibi, in particolare distinguendo fra quelli consentiti o vietati, prescrivendo norme digiunali, codificando rituali: per la presunta salute dell’anima, o anche solo per assecondare un capriccio divino.
L’ultima cena del Cristianesimo (ed il derivato rito della comunione) mostra forse più di ogni altro esempio questo legame fra l’alimentarsi ed il divino, da cui un intrecciarsi di norme, fra le quali spicca la moderazione a tavola, spinta talora patologicamente fino all’astinenza più o meno totale e variamente scandita temporalmente da acqua e cibo.
Nelle varie religioni, premesso che il ‘peccato di gola’ è sempre biasimato (anche perché stimola altri piaceri), la linea di confine fra prescrizione rituale e tabù è piuttosto incerta. Nel cristianesimo, ad esempio, si prescrivono il digiuno rituale in alcune circostanze particolari (come il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo) ed il divieto di consumare carne il venerdì, ma non si dichiarano precisi tabù; cosicché gli atti simbolici prevalgono assolutamente sulle prescrizioni ‘igieniche’, quali ad esempio previste dall’ebraismo e dall’islamismo (si noti a tal proposito la discordanza fra l’ossessione degli ebrei per la pulizia rituale del corpo e l’assoluto disinteresse degli induisti per tutto ciò).
Storicamente il cristianesimo non ha particolari idiosincrasie alimentari, ed anzi la cucina dei religiosi e delle religiose è sempre stata quanto mai varia ed abbondante, estremamente differenziata secondo le stagioni ed il calendario liturgico, al punto che si potrebbe ben parlare di una vera e propria ‘teologia culinaria’ fatta di privazioni, digiuni ed astinenze in periodi comandati, ma anche di gaudenti tradizioni gastronomiche legate ai vari culti dei santi.
Ben altro discorso va fatto per l’ebraismo, religione dei divieti e dei mille rituali, le cui leggi alimentari vengono ritenute le più antiche della storia. Il loro insieme costituisce il Kosherut, che elenca tutto ciò che è ‘lecito’, in base all’idea di fondo che la cucina sia un tabernacolo, mentre il tavolo è l’altare. In base all’arcaico libro del ‘Levitico’ vi è infatti una netta distinzione fra cibi ‘kashèr’ (ovvero leciti) e cibi ‘non kashèr’ (ovvero ‘empi’, al di fuori da ogni logica oggi a noi accettabile), e vengono prescritte precise norme di uccisione degli animali, e di cottura e mescolanza degli alimenti. Per l’ebreo praticante nutrirsi ‘kosher’ è anche una sorta di marchio che dimostra la piena appartenza alla comunità.
L’islam è altrettanto rigoroso e pretende una piena sottomissione alla ‘volontà di Allah’: l’infrazione alimentare (così come la non aderenza alle varie altre proibizioni ed alle preghiere rituali) viene considerata una diretta offesa alla divinità, severamente punita. Ciò che è ‘Halāl’ (lecito) viene contrapposto a ciò che è ‘harām’ (proibito). Molte carni (ad esempio: maiale, asino, uccelli rapaci, rettili, pesci privi di scaglie) sono bandite dalla tavola, oltre alle bevande alcoliche.
Nel buddhismo, religione della moderazione in qualunque campo della vita, è raccomandata l’astinenza dalle carni degli animali terrestri, per rispettare la vita di esseri senzienti, salvo alcune previste eccezioni e purché non si sia partecipato all’uccisione dell’animale; ma si consiglia l’astinenza dal pesce e dai formaggi stagionati.
Per gli induisti è colpa grave provocare la morte di qualunque essere vivente, perché sede di un’anima che sta scontando gli errori e le colpe di una vita precedente; e vengono rifiutati perfino alcuni ortaggi (aglio, cipolle, carote, rape, legumi rossi).
In base ad un principio di rispetto della vita quanto mai estensivo, anche i giainisti rifiutano la carne, ma neanche calpestano i ragni, né lavorano la terra, per non uccidere gli insetti che vivono nelle zolle.
Come è ben chiaro, le religioni hanno soprattutto un rapporto fortemente conflittuale con le carni. La mentalità arcaica che inevitabilmente le pervade è infatti esitante di fronte alla ‘animazione del corpo’ ed alla capacità senziente, e non a caso la macellazione ebraica e islamica prevede il completo dissanguamento. Ma questa idea confligge con l’evidenza della natura ‘onnivora’ dell’essere umano, che ha sempre mangiato le carni animali, ed il cui apparato digerente non è certo quello degli erbivori. Anzi, secondo alcuni ricercatori, le supremazia del cervello umano va proprio messa in relazione al nostro appetito per la carne ed al numero di calorie (prevalentemente derivate dalla carne) consumate ogni giorno.
Qui comunque i preconcetti religiosi si intersecano con presupposti di altro genere: infatti presso molte popolazioni vengono considerati non commestibili gli animali domestici (ai quali si attribuisce una coscienza) e quelli selvatici, mentre si ritengono commestibili quelli d’allevamento o da caccia, con ampie discrepanze fra i diversi contesti geografici (in Inghilterra, a esempio, non si mangia la carne del cavallo, considerato animale da compagnia; in oriente si mangia la carne del cane).
Per meglio comprendere il significato dei tabù alimentari religiosi, va detto qualcosa anche sulla loro presunta origine, che ne chiarisce spesso una chiara motivazione utilitaristica, poi evolutasi in vera e propria ‘dietologia divina’. Secondo certe interpretazioni, la ‘Torah’ ebraica obbligherebbe i macellai a dissanguare le carni degli animali di grossa taglia, habitat ideale per lo sviluppo di micidiali microrganismi; per gli indiani i bovini erano più preziosi da vivi (latte tutti i giorni, burro, formaggi, yogurt…) che macellati, ed inoltre fornivano abbondante concime; la carne di cavallo è stata bandita dai cristiani in quanto considerata alimento dei popoli pagani, dei barbari e dei selvaggi; alcune tribù indigene americane rispettavano il coyote perché abile, intelligente, ritenuto legato alla creazione dell’universo e autore del furto del fuoco agli dei; gli islamici non mangerebbero il maiale in quanto animale che vive nell’immondizia o perché il suo allevamento aveva un tempo un alto costo sociale rispetto ad altri animali, o forse anche per la sua ricchezza di grassi saturi; le scimmie sono rispettate dagli indù in quanto considerate la reincarnazione del loro dio scimmia.
Come se tutto ciò non rappresentasse già una patologia del pensiero, che dovrebbe invece ben aprirsi ad un sano edonismo alimentare, merita almeno un cenno la possibilità che (per specifiche elaborazioni settarie) pratiche come il digiuno o norme alimentari fondate su prescrizioni religiose (anche se in origine del tutto lecite e innocue) possano ispirare azioni e comportamenti estremi, fino a provocare la morte dei propri adepti, come in molti casi di imposto o volontario prolungato digiuno.
Detto questo va sottolineato come, inversamente, determinati comportamenti alimentari sono essi stessi una sorta di religione. Secondo qualche analista, infatti, seguire una dieta ‘virtuosa’ è oggi la religione più praticata, alla ricerca della salvezza del corpo e non dell’anima, nell’illusione di controllare pienamente la propria vita, e l’ideale di salubrità si identifica spesso proprio in un cibo salvifico.