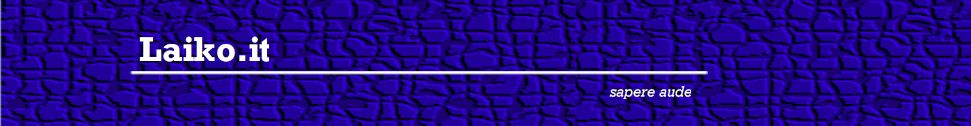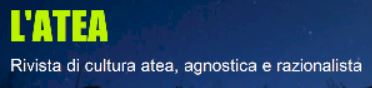Aggiungi il gatto in tavola?
L’inopportuna descrizione del miglior modo per preparare e cucinare il gatto è stata recentemente il casus belli di una inopinata quanto fugace polemica giornalistico-televisiva sull’utilizzo culinario di alcune specie animali. L’improvvido Beppe Bigazzi aveva infatti ricordato in diretta televisiva (a “La prova del cuoco”, del 10 febbraio 2010) come dalle sue parti (nella Val d’Arno degli anni Trenta e Quaranta, a Febbraio) si cucinava tradizionalmente il gatto (al posto del coniglio), come tale usanza fosse riemersa per necessità durante il periodo bellico, e come la carne di gatto sia in effetti “molto più buona di tanti altri animali”. Che ciò rappresentasse un chiaro invito a cibarsi dell’amato felino (piuttosto che una semplice nota storica) è dubbio, ma la sensibilità degli animalisti ne è stata comunque offesa.
Quale animale da compagnia e da affetto, è indubbio che il gatto goda infatti nella nostra società di considerazione e privilegi, così come cani, uccellini, criceti e vari altri. Ma qual è il fondamento di tale rispetto, quale l’origine del turbamento a cibarsene? Si tratta di amore per l’animale in sé, o di una forma raffinata di antropomorfizzazione della natura? Pretendiamo rispetto per l’animale o, più egoisticamente, solo per i nostri sentimenti? E perché ci cibiamo invece di conigli ed agnelli, che ci fanno tanta tenerezza?
Vero è che secondo la legge sul randagismo (n. 281 del 1991) “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”, ma questo vuol dire che non sia lecito mangiare il gatto o altro animale da affezione morto? e che non sia possibile ucciderli a scopo alimentare senza maltrattamento e crudeltà? Ed infatti l’art. 544-bis del Codice Penale sancisce che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”. Ma se uno il gatto lo mangia proprio per necessità? Come non ricordare il pasto antropomorfo dei sopravvissuti ad una sciagura aerea sulle Ande, qualche decennio orsono, il cui comportamento sconcertò, ma poi a mente fredda venne ritenuto giustificato in base alla estrema necessità?
Tanto per non creare equivoci, sia ben chiaro che non intendo schierarmi contro cani e gatti, ma semmai rivendicare pari dignità di trattamento per altri animali verso i quali non siamo egualmente rispettosi, ad esempio i bovini, i suini, ed il pollame: allevati ed uccisi in modo ‘disumano’; o anche gli animali da spettacolo (tori da arena, cavali da corsa) maltrattati gratuitamente e con ferocia aguzzina.
Il comune senso di pietà per questi animali sembra infatti del tutto obnubilato allorchè ci si ingozza di panini all’hamburger, sublime trasformazione di un essere vivente in informe massa proteica.
In tal senso, la sollevazione contro Bigazzi e contro la sua ricetta ‘storica’, riconosciamolo, sa molto di ipocrisia.
Ma torniamo alla legge del 1991 che intende “favorire la corretta convivenza tra uomo e animale”. Questo è il punto nodale: qual è la corretta convivenza fra uomo ed animale?
Come chiunque può constatare, nella società umana, assolutamente onnivora, cibarsi di carne animale turba una ristretta minoranza. Anzi, altri popoli hanno usanze ancora più radicali delle nostre occidentali e non rispettano la vita di quasi nessun animale opportunamente mangiabile (si racconta, ad esempio, che i cinesi mangiano tutto quello che nuota meno le barche, tutto quello che vola meno gli aerei, tutto quello che cammina meno gli esseri umani). Dalle nostre parti invece si è da tempo consolidato un rispetto per alcuni animali che abbiamo in qualche modo adottato; anche se, contraddittoriamente, mangiamo il coniglio comprato al supermercato mentre ci sconcerta pensare altrettanto del nostro coniglietto da compagnia. E che dire dei poveri cervi, dalla carne prelibatissima?
Si tratta evidentemente di una questione di scelta; ma in base a che cosa? All’intelligenza? In tal caso polpi e maiali sono senza dubbio intelligenti. Alla simpatia? Che dire degli agnellini per i quali ogni Pasqua equivale ad un quasi genocidio?
Riconosciamolo; per lo più siamo vittime di una ipocrisia culturale, di un razzismo di specie, che decide arbitrariamente quale essere vivente vada rispettato, e fino a che punto. Ed ogni cultura ha inversamente i suoi tabù, anche di segno assolutamente opposto. Dunque noi europei siamo disprezzati dagli indiani perché mangiamo la mucca e dai musulmani perchè mangiamo il maiale; mentre noi disprezziamo i cinesi perché mangiano volentieri cani e gatti; e così via. Non dovremmo disprezzare noi stessi perché mangiamo comunque così tanta varietà di animali?
Ma proviamo anche a considerare le argomentazioni di chi non vede nulla di male nel mangiare cani e gatti. Perché dovremmo rispettare a tal punto un animale che per istinto tormenta a sua volta i topi, gli uccelli ed ogni altro piccolo animale che cattura, anche se non intende cibarsene? Perché dovremmo avere così tanto rispetto per esseri così ‘irrazionali’ e crudeli?
Forse non c’è una soluzione a questo quesito; o almeno io non so proporne una inattaccabile. Si può, tuttavia, per lo meno accennare alla storia di questo dibattito, che mescola senso pratico ed ideologie.
La nascita del sentimento moderno verso la natura, inteso anche come nostalgia per un mondo dal quale la civiltà si allontanava sempre di più, risale ad un periodo compreso fra il Quindicesimo ed il Diciottesimo secolo. Alla logica dello sfruttamento senza regole della terra e dei suoi beni, ritenuti sulla scia del dettato di Genesi del tutto assoggettati ed assoggettabili dall’uomo (giacchè il mondo sarebbe stato creato proprio per il bene del solo uomo) si oppone infatti gradualmente una ridefinizione del posto occupato dall’uomo entro la “scala naturale”. Da qui deriva un nuovo sentire nei confronti degli animali, delle piante e del paesaggio, che genera crescenti dubbi ed inquietudini sulla moralità della logica predatoria. Se la storia umana ha avuto come elemento fondamentale l’affermazione di questo primato dell’uomo, ciò è dovuto infatti anche a come l’uomo stesso ha razionalizzato un estremo antropocentrismo: a cominciare proprio dal testo biblico e dalla filosofia greca.
Nella predicazione cristiana, ancora agli inizi dell’epoca moderna, ogni specie animale veniva intravista proprio in funzione di una particolare utilità per l’uomo, dall’aiuto nel lavoro all’essere servito in tavola. Ed ancora ai primi del Settecento, in Occidente, all’animale non veniva riconosciuto alcun diritto, al punto che gli si poteva dare qualunque destino o morte fossero richiesti dalla nostra necessità di cibo o perfino dal nostro diletto; atteggiamento del tutto contrario a quanto esibito negli stessi secoli da quei popoli orientali che invece predicavano (con sconcerto dei nostri esploratori) il rispetto della vita animale. Se nel mondo occidentale almeno alcuni animali venivano destinati invece ad uno scopo morale o estetico, ciò lo era non in funzione di essi stessi, ma sempre entro l‘ottica umana di un loro utilizzo.
La storia dell’alimentazione riflette pienamente questi mutamenti di atteggiamento. L’uomo è onnivoro per antonomasia, e dunque avvezzo da sempre a cibarsi di tutto quanto trova commestibile, in particolare di ogni altro essere vivente; e ciò costituisce un atteggiamento naturale, probabilmente ineludibile, anche se mitigatosi dopo la nascita dell’agricoltura. Ma nel corso della civilizzazione molte specie sono tuttavia uscite dall’elenco delle specie edibili, in particolare gli animali da compagnia e d’affetto.
Il cristianesimo ha in questo importanti responsabilità (per lo meno a causa della sua centralità, per molti secoli, nel pensiero occidentale. La razionalizzazione del predominio incondizionato dell’uomo sulla natura si fonda infatti in gran parte sui libri sacri. All’opposto, l’estetica della natura viene combattuta a lungo dal cristianesimo, in quanto richiama troppo da vicino i culti pagani delle fonti, dei fiumi, dei campi, dei boschi. La tardiva presa di coscienza dei pericoli prima dello sfruttamento incondizionato e poi dell’inquinamento dell’ambiente è frutto proprio di tale atteggiamento, che ha comunque ampio fondamento anche in altre religioni.
Se oggi alla logica dello sfruttamento si va sostituendo (almeno si spera) una logica della responsabilità e del rispetto, ancora per l’uomo del Sei-Settecento conoscere la natura significava poterla meglio dominarla e sfruttarla; e si considerava progresso ciò che distingue il civilizzato dal “selvaggio”.
Tutto dunque appariva lecito a beneficio dell’uomo, anche in campo alimentare; e la natura ne risultava paradossalmente quasi esaltata. Così nel 1634, il poeta Thomas Carew, scriveva: “La pernice, l’allodola e il fagiano / volavano alla tua casa come a un’Arca. / E il bue di buon grado veniva / al macello assieme all’agnello; / e ogni bestia colà si recava / per fare offerta di sé.”
Se nel mondo odierno esiste (o dovrebbe esistere) una remora all’infliggere trattamenti dolorosi e la morte alle altre specie viventi, non altrettanto si può dire della disponibilità al cibarsi delle carni di quegli stessi animali che non ci sentiremmo personalmente di uccidere (dunque la nostra etica è assolutamente incoerente). Questa inibizione non esisteva nel pensiero greco, come poi non comparve in quello cristiano, nel quale l’uomo ha uno statuto ontologico del tutto peculiare.
Non solo, in questa logica, l’alimentarsi con altre specie animali rappresenta un pieno diritto dell’uomo, ma il modo stesso di alimentarsi certifica tale diritto: infatti l’uomo, a differenza degli animali ‘bruti’, cuoce le carni e le mangia senza imitare il loro disgustoso modo di cibarsi.
Uno dei connotati dell’ animalismo attuale è l’accostare alcune specie animali all’uomo, cosa del tutto opposta alla “presunzione” (tanto aborrita dagli spiriti candidi dei secoli passati) di avvicinare l’uomo agli altri animali (per la similarità delle funzioni corporee, della sessualità, etc…).
Nell’Inghilterra del Sei-Settecento, ad esempio, il mescolamento delle categorie umana ed animale (a partire dall’accoppiamento sessuale, fino al semplice travestimento teatrale) era visto come un atto nefando; da qui i divieti di familiarità stretta con gli animali da compagnia: che infatti, secondo il galateo, non dovevano sedere a tavola, e quindi furono allontanati progressivamente dagli spazi domestici, esclusi pochi fra loro.
L’uomo civilizzato, inurbato, perse così gradualmente la familiarità di sempre con gli animali (e con la natura stessa, nelle sue svariate articolazioni) e ciò probabilmente contribuisce oggi ad accrescere il distacco emozionale fra lui e le altre specie viventi, eccetto quelle che gli offrono compagnia ed affetto, anch’esse quasi separate, proprio per tale motivo, dal restante mondo animale. Di conseguenza della bestia selvatica si può ancora far tutto (anche perché la macellazione viene delegata ad altri), mentre la domestica è protetta e coccolata. E tanto più viene ignorata la bestia, quanto più le sue carni sono servite dopo un trattamento che ne nasconda la natura e provenienza.
In definitiva, l’uomo moderno che protegge il proprio animaletto preferito lo rende in un certo senso anche esso ‘cosa’, giocattolo, al di là delle sue caratteristiche specifiche. L‘animalismo puro ha invece ben altri obiettivi e ben altra coscienza; predica più ampio rispetto per il nostro fratello animale, visto per quello che è; e per fortuna sembra in crescita costante. Ma nonostante ciò, l’utilizzo alimentare dei viventi, specie contro specie, appare ben lungi dall’essere risolvibile.