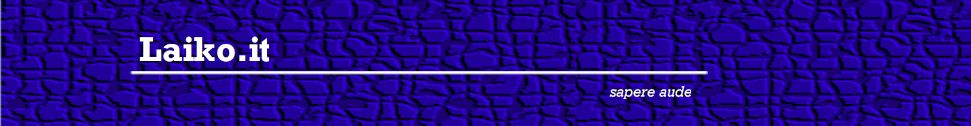Il laboratorio del razzismo
di Francesco D’Alpa
[L’ATEO, 1/2018]
Dopo la fondazione, nel 1859, della ‘Società Parigina di Antropologia’ (il cui intento era quello di analizzare e definire in termini biologici le differenze razziali, classificando dei ben precisi ‘tipi razziali’ sulla base di analisi comparative anatomiche e fisiologiche), la Francia divenne il primo grande laboratorio del razzismo, favorendo l’elaborazione del concetto di ‘supremazia ariana’.
Nell’ambiente medico positivista si generò una sorta di ossessione antropometrica: ogni caratteristica psicologica venne ben presto correlata a caratteristiche somatiche quali il peso del cervello, la forma del cranio, alcuni indici facciali; l’ineguaglianza somatica fu considerata rivelatrice delle ‘evidenti’ ineguaglianze intellettive e morali. Si affermò il principio che le scienze mediche fossero le più indicate a chiarire le ragioni delle rilevanti differenze fra i popoli (viste ora come solo in parte culturali) descritte fino ad allora dagli antropologi. Studiosi peraltro eminenti come Paul Pierre Broca (1824-1880), diedero purtroppo un supporto (a quei tempi ritenuto ‘scientifico’, dunque rispettabile) all’idea che l’aspetto fisico fosse non solo un riflesso, ma perfino una ‘determinante’ del carattere morale e intellettuale dell’individuo; la scienza finì per inquinarsi con una pseudo-biologia, nella quale elementi come le dimensioni della pelvi, la forma del naso o quella del cranio vennero eretti a sistema identificativo della superiorità o inferiorità razziale.
La questione razziale alimentò non poco la diatriba fra monogenismo e poligenismo. Secondo i monogenisti, sostenitori di una secolare tradizione religiosa, che nel primo Settecento aveva trovato un forte sostegno scientifico in Georges Cuvier (1769-1832) e Geoffroy de Saint-Hilaire (1772-1844), le differenze razziali potevano essere spiegate in base ad un adattamento ai diversi ambienti di vita, ad un successivo intervento divino, oppure ad una degenerazione rispetto al modello primitivo. Secondo i poligenisti, che facevano riferimento soprattutto all’opera di Julien-Joseph Virey (1775-1846), le differenze razziali erano più facilmente spiegabili ipotizzando un originario spettro di famiglie umane. Dunque le differenze etniche potevano essere definite innate e permanenti, impermeabili ad esempio al trasferimento di individui o di intere popolazioni da un habitat all’altro (cosa che si credeva dimostrata dalla persistenza, secolo dopo secolo, dei caratteri somatici originari nei discendenti di neri africani trasferitisi in Europa ova di bianchi europei trasferitisi in Africa). Spingendosi più in là, alcuni poligenisti (fra i quali spicca Georges Pouchet, 1833-1894) giunsero ad affermare che certe popolazioni africane dovevano essere escluse dalla specie uomo, in quanto somaticamente più prossime alle scimmie.
Su queste basi, il tema della fertilità ‘interrazziale’ non poteva non appassionare gli studiosi. Secondo i monogenisti, la loro tesi era supportata dall’evidenza che gli incroci fra i vari gruppi umani sono sempre fertili nelle generazioni successive, a differenza di quelli fra specie animali per quanto vicine. I poligenisti controbattevano con una spiegazione messa in campo da Broca, ovvero che l’esistenza di specie diverse di umani era ben comprovata dall’inferiorità (per longevità, vigore, salute, intelligenza) di quanti nati dal loro incrocio. In definitiva, secondo entrambi i gruppi contendenti, l’ineguaglianza ‘ineliminabile’ delle razze umane ben legittimava la supremazia dei bianchi, il colonialismo e lo schiavismo.
Dal punto di vista scientifico, i poligenisti ebbero la meglio, e ciò del tutto indipendentemente dalla ricezione delle teorie darwiniane, che piuttosto vennero accolte in Francia solo in un secondo momento, tardivamente rispetto ad altre nazioni. Ma quando questo accadde, l’effetto fu in qualche modo devastante, in quanto consentì ai poligenisti di rafforzare le proprie tesi, andando ben oltre l’idea originaria di selezione naturale, forzandola ancor più in senso razzista.
Tutto oramai convergeva verso la definizione ‘scientifica’ di un modello umano ideale: quello occidentale ariano; uomini di pelle bianca, di comprovata superiorità intellettuale, tecnologica, spirituale, morale; al vertice di una ineliminabile ‘scala umana’.
Il momento chiave nel quale il concetto di ‘tipi razziali’ venne legato irreversibilmente al ‘razzismo’ propriamente detto fu la pubblicazione fra il 1853 ed il 1855 del voluminoso (ed ingombrante!) “Essai sur l’inegualitè des races humaines” di Arthur de Gobineau (1816-1882). L’idea guida di questo autore (un diplomatico con alle spalle una serie di lunghi soggiorni in varie nazioni del Vecchio e del Nuovo Mondo) era l’evidente superiorità della razza (e dunque della civiltà) ‘ariana’ (e soprattutto cristiana) rispetto alle altre due presenti sulla terra, l’asiatica e l’africana. Secondo Gobineau, l’incrocio fra individui appartenenti a razze diverse può in qualche modo fonderne alcune attitudini, ma provoca un indebolimento dei caratteri originari da cui deriva la già evidente decadenza della civilizzazione ‘ariana’ (che a suo parere sarebbe crollata entro 6000 anni, seguita dall’inevitabile estinzione della specie umana).
Come ben sappiamo, il tema della degenerazione degli individui e delle popolazioni, legata a cause le più disparate, ammorberà lo scientismo fra Ottocento e Novecento.
Nota: Questo articolo sintetizza parte di quello di Jarries Ferguson (fellow alla St. Edmund Hall, Oxford) apparso, con lo stesso titolo, nel “New Scientist”, vol. 103, n. 1423, del 27 settembre 1984, pp. 16-20.