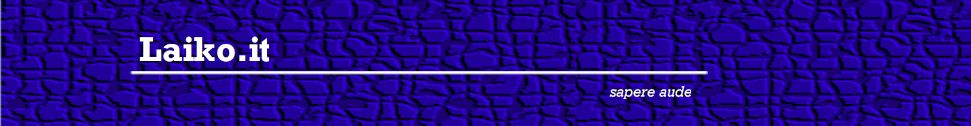La teologia in favore della pena di morte
La chiesa cattolica ha seguito a lungo l’impostazione di Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino, insegnando che il cosiddetto ‘bene comune’ (più tardi accettato anche come ‘ragione di stato’) è un principio superiore di giustizia, in nome del quale è possibile uccidere legalmente il colpevole, anche per reati diversi dall’assassinio. Dunque l’uccisione legale viene posta su di un piano diverso rispetto al comune assassinio, come del resto già previsto nella legislazione mosaica.
Infatti, anche se il quinto comandamento delle “Tavole delle Leggi” consegnate a Mosè recita
«Non uccidere» (Esodo 20, 13 ; Deuteronomio. 5,17)
gli stessi scritti ‘mosaici’ precisano quale ne è il senso più ampio:
«Non far morire l’innocente e il giusto, perché io non assolverò il malvagio» (Esodo 23, 7).
Dunque il divieto non è assoluto; e la morte del colpevole è tuttaltro che una deroga al principio generale.
Il “Nuovo Testamento”, intervenendo sull’argomento, recita:
«Gli si presentò uno dicendo “Maestro, qual bene dovrò fare per avere la vita eterna?” […] Gesù rispose: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso» (Matteo 19, 16-19; similmente Marco 10, 17-19).
Paolo di Tarso ribadisce nella “Lettera ai Romani” (13, 8-9) quanto riportato da Matteo e Marco, ma premette, nello stesso capitolo:
«I magistrati non sono di timore per le buon azioni, ma per le cattive. Vuoi tu non aver paura dell’autorità? Diportati bene e riceverai la sua approvazione. Essa è infatti ministra di Dio per il tuo bene. Se invece agisci male, temi; non per nulla essa porta la spada: è infatti ministra di Dio, esecutrice di giustizia contro chi fa il male» (Romani 13, 2-4).
Allo stesso modo Bernardo di Chiaravalle all’inizio del XII secolo legittima le ‘guerre sante’ sostenendo:
«Un soldato di Cristo […] senza dubbio quando uccide un malvagio non è un omicida, ma, per così dire, un uccisore del male e viene stimato vendicatore di Cristo nei confronti di coloro che fanno il male e difensore dei Cristiani»
«Disperdere questi gentili che vogliono la guerra, eliminare questi operatori di iniquità che vagheggiano di strappare al popolo cristiano le ricchezze racchiuse in Gerusalemme […] ecco la più nobile delle missioni».
La distinzione netta fra il precetto di ‘non uccidere’ arbitrariamente e la piena legittimità dello ‘uccidere in nome della legge’ (o in nome di Dio) è evidente, e non a caso la si è ribadita quasi fino ad oggi. Gesù, secondo una lettura senza preconcetti del “Nuovo Testamento”, non ha infatti per nulla contraddetto tale distinzione, come dimostra la sua stessa morte.
Antico Testamento alla lettera
Fra il Cinquecento ed il Seicento, la chiesa presbiteriana propone un’applicazione alla lettera del modello legislativo veterotestamentario:[1] la giustizia va esercitata senza alcuna discrezionalità suggerita da consenso, costume, abitudine, ed esigenze politiche di «civiltà ed ordine».[2]
In supporto viene citato anche Paolo di Tarso:
«sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio» (I Corinti, 10, 31).
Ciò che Paolo afferma del cibo deve considerarsi estendibile a tutto ciò che il cristiano fa ed usa. L'agire del cristiano viene basato sull'obbedienza e non c'è obbedienza più necessaria di quella al comandamento di Dio. Nulla può dunque essere considerato ‘indifferente’. La chiesa deve applicare alla lettera quanto compare nel testo sacro, e l’autorità del principe non può mutare le leggi sacre:
«La Chiesa di Dio era perfetta prima che ci fosse un qualche principe cristiano. Anzi, la Chiesa di Dio può reggersi, ed invero oggi si trova in una condizione felice, anche dove i magistrati civili non la favoriscono. È evidente dunque che il governo della Chiesa non dipende dall'autorità dei principi, ma dall'ordinanza di Dio che l'ha misericordiosamente e saggiamente stabilita in modo che fiorisca e prosperi con l'aiuto dei magistrati cristiani, e tuttavia può continuare in vita e prevalere sui suoi nemici anche senza il loro aiuto. La Chiesa chiede aiuto e protezione ai principi cristiani per continuare ad erigere il regno di Cristo in modo pacifico e proficuo. Essa riceve però tutta la sua autorità immediatamente da Dio».[3]
Esercizio inflessibile dell’autorità (atto a tenere gli uomini in soggezione) e pubblico biasimo sono strumenti ordinari del potere, che vede nell’esemplarità della pena il più efficace deterrente ad ogni crimine, a partire da quelli elencati nella “Prima lettera ai Corinti”: l'incontinenza sessuale, l'avidità, l'idolatria, la calunnia, l'ubriachezza, l'estorsione.[4] Dove non arriva il timore delle pene terrene, supplisce quello per le pene eterne.
Secondo il teologo puritano Thomas Cartwright, Cristo aveva abrogato solo le norme cerimoniali, non quelle morali e politiche. Dunque bisognava continuare e ritenere ‘eque’ le leggi di condanna a morte per reati quali l’idolatria, la bestemmia, l’omicidio, l’incesto; il magistrato doveva perfino essere contento di giudicare secondo lo stesso parere dello Spirito Santo. Dio aveva esplicitamente istituito la pena di morte dandole una motivazione religiosa e non secolare.
Col pieno supporto della teologia
Così come in passato, anche oggi molti religiosi mantengono posizioni chiare e dettagliatamente motivate in favore della legittimità della pena di morte, come ad esempio il passionista Thomas M. Tyn, che si appoggia ad argomenti assolutamente tradizionali. Secondo lui, occorre considerare innanzitutto l’argomento morale:[5]
«il diritto alla vita non compete all'uomo in virtù del suo essere umano fisicamente considerato, bensì tramite il suo essere ben più profondo e ben più specificamente umano ch'è quello morale. Il diritto alla vita rimane un valore imprescindibile ed assoluto, ma non tutti gli esseri umani hanno sempre e comunque diritto alla vita; si danno dei casi nei quali il diritto può essere perso e di fatto è perso. Là dove tale diritto vige, esso va osservato scrupolosamente come valore morale e per conseguenza come bene assoluto, ma l'estensione di tale diritto ammette eccezioni e, in questo senso, limitazioni. Se infatti l'uomo possedesse il diritto alla vita come possiede la vita stessa, ovvero fisicamente, allora sì che chiunque ha la vita non potrebbe mai esserne lecitamente privato. In tal caso i soggetti dotati del diritto suddetto sarebbero esattamente tanti quanti sono ì soggetti fisicamente viventi di vita umana. Senonché il diritto alla vita, essendo valore morale e non fisico, non si può legittimamente confondere con la vita stessa che invece, lungi dall'essere un valore morale, non è altro che un bene prettamente ed esclusivamente fisico».
Vediamo come questo argomento viene concretamente applicato nel caso della pena di morte:
«Vi è, nel mondo cattolico e fuori dì esso, chi tende a minimizzare questioni come la liceità della pena di morte o quella della guerra giusta. Contro le inequivocabili prese di posizione del Magistero ecclesiale (DS 795) si suole controbattere che si tratta di verità suscettibili di cangiamento con lo sviluppo della civiltà da costumi più selvaggi e rozzi a leggi di convivenza più umana e raffinata. Si tratterebbe in fondo di questioni del tutto secondarie in quella che di solito si chiama "gerarchia delle verità". Ora, a parte la predilezione, tipicamente modernistica, di quelli tra i figli della Chiesa, che non sono dei più fedeli ed esemplari, a datare ogni pronunciamento magisteriale e a maneggiare la scala delle verità con una disinvoltura che minaccia di trasformarla piuttosto in una graduatoria di bugie sottilmente sfumate, rimane il fatto che nelle soluzioni contrapposte del problema dell'universalità o meno del diritto alla vita si celano due concezioni di etica e di dottrina morale fondamentalmente e radicalmente opposte. Non si tratta di quisquilie modificabili a piacimento, ma di contenuti della legge morale naturale dei quali o si riconosce la portata metafisica, superiore alla fisicità dei fatti biologici e quindi la specificità morale o lì si riduce alla fenomenicità materiale dello stesso dato fisico con conseguenze disastrose per le sorti della moralità ut sic. Basta pensare alla mentalità corrente che scagiona impudentemente l'aborto, mentre con lo stesso fiato denuncia la ferocia barbarica della pena capitale. Ebbene la differenza è proprio qui: tra chi ritiene che il criterio decisivo stia nella linea di demarcazione tra innocente e reo (realtà morali metafisicamente e obiettivamente fondate) e chi invece riduce tutto alla sola diversità, del tutto soggettiva, fenomenica, materialisticamente fisicistica, di un organismo più o meno sviluppato e capace di sopravvivenza autonoma. Vogliamo dire che si tratta di cose serie che implicano al di là dei temi particolari la base stessa della moralità e ribadiamo altresì che in questa materia il magistero della Chiesa non può ammettere arbitrari mutamenti, pena il decadimento totale della stima dì cui esso gode negli stessi tempi nostri. Infatti, se qualche Papa medievale ha sbagliato in una materia così gravosa nel contesto di una solenne dichiarazione, non sì vede perché non potrebbe sbagliare anche il magistero attuale e, se si dice, assai modernisticamente, che l'attualità è comunque un innegabile vantaggio, non si sfugge alla domanda della "durata" di quella effimera attualità (1 anno, 10 anni, 100 anni per i "dogmi" più robusti?). Siamo nel ridicolo. Infine ci sia permesso di premettere che, certo, de gustibus non est disputandum, ma che ciononostante troviamo perlomeno sconcertante quella concezione del progresso che si limita ai soli fatti di civiltà ignorando ottusamente quelli della cultura veramente degna di tal nome - che i chirurghi moderni ammazzano i feti con bisturi sofisticatissimi, mentre il boia medievale mozzava le teste ai delinquenti con scuri rozze segna un innegabile miglioramento dal punto di vista tecnico, ma, per anime che non hanno ancora del tutto perso il senso della moralità, ciò significa un altrettanto innegabile decadimento dal punto di vista umano, perché, se al reo la testa può essere anche talvolta de iure tagliata, non vi è nessuna legittimazione per il massacro di soggetti moralmente e per conseguenza anche giuridicamente del tutto innocenti».
Il secondo argomento è quello del fine: la sopravvivenza fisica non può essere considerata il fine ultimo dell’uomo, che è invece il suo destino trascendente; dunque il corpo è solo un mezzo, e non può essere messo in cima ai valori, a pena di cadere nel materialismo ateo:
«il suo possesso sarà un bene utile e non un bene onesto o morale. Sarà al contrario un bene morale onesto ed assoluto il dovere di rispettare la vita in chi ha diritto alla vita, ma non chiunque dì fatto (fisicamente) possiede la vita avrà anche diritto a possederla indipendentemente dalla sua qualità morale». Inoltre, «dato che la vita costituisce un bene fisico, supremo sì nell'ambito dei beni fisici, ma sempre e solo fisico, la vita umana dovrà essere arrischiata là dove lo richiede il bene della società (ad esempio nella difesa della patria) o anche tolta per sentenza giudiziaria (ad esempio applicando la pena capitale là dove la vita associata non potrebbe svolgersi serenamente lasciando sopravvivere il delinquente)».
Il terzo argomento si rifà al principio del bene comune, ed è quello della protezione degli onesti:
«se la sopravvivenza fisica del delinquente comporta un prossimo pericolo per la sopravvivenza degli onesti cittadini, lo Stato commette un'ingiustizia lasciando sopravvivere il delinquente pericoloso per la società stessa perché potenziale aggressore al bene morale della sopravvivenza degli innocenti che hanno, questi sì, il diritto imprescindibile alla vita, diritto che la comunità politica deve comunque tutelare. Similmente, se una comunità politica aggredisce l'indipendenza e la sovranità di un'altra, quest'ultima non solo ha il diritto, ma ha altresì il preciso dovere di difendersi, perché la sua difesa non concerne qualche diritto individuale al quale si potrebbe anche lodevolmente rinunciare, ma il diritto dì tutti gli associati che è amministrato ma non posseduto dai governanti. E se il Vangelo ci insegna a porgere l'altra guancia a chi ci percuote (cf. Mt 5, 39), è nella natura stessa della cosa che chi compie quel nobile gesto si premuri di rinunciare ai diritti suoi propri, ma non certo a quelli altrui, che badi, in breve, a porgere la guancia sua e non quella del suo prossimo».
Così come si è sostenuto sia all’epoca dei padri che durante la tomistica,
«il delinquente, per il fatto stesso di volere commettere il delitto, deliberatamente si priva del diritto alla vita -l'essere morale qualifica l'uomo ben più profondamente del suo essere fisico. Quel fine pensatore al trono di San Pietro che fu l'indimenticabile Pontefice di venerata memoria Pio XII disse in uno dei suoi discorsi: "Anche laddove si tratta dell'esecuzione di un condannato a morte lo Stato non dispone del diritto dell'individuo alla vita. Resta riservato in tal caso all'autorità pubblica il potere di privare il condannato del bene della vita in espiazione della sua colpa dopo che egli, per il suo delitto, si è già privato del suo diritto alla vita" (AAS, 1952, pp. 779 ss... - la traduzione è nostra). Checché ne dicano i neoterici della crudeltà della pena di morte e addirittura della sua contrarietà al Cristianesimo, ogni buon cattolico si sentirà in compagnia assai rassicurante accanto a quel grande Papa del nostro tempo. Dato comunque che la vita dell'aggredito e quella dell'aggressore, considerati entrambi come persone private, è in astratto "alla pari", solo nell'atto concreto dell'aggressione sorge una disparità a favore dell'aggredito così che questo si può difendere durante l'attuale svolgimento dell'aggressione senza cercare l'uccisione dell'avversario, eppure arrivando persino ad ucciderlo di fatto».
Una delle principali obiezioni a questo modo di vedere, secondo una concezione cristiana della vita, potrebbe venire da riserve morali sull’eventuale pregiudizio, conseguente alla pena, per la salvezza eterna del condannato. Ma il nostro predicatore respinge facilmente l’obiezione, basandosi sempre su temi catechesici consolidati:
«Per quanto concerne la pena di morte si è sempre avanzata l'obiezione fideistica di privare il prossimo del suo diritto alla salvezza. Ora non è bene capovolgere le parti - ognuno può pentirsi in ogni momento, ché Dio gliene dà la grazia sufficiente, se dunque non si pente, la colpa è interamente sua. Inoltre ciò che è buono nell'ordine più fondamentale della natura non è tolto in quello, sebbene più sublime, della grazia, dimodoché, se la pena capitale è legittima iure naturali, lo è anche iure divino positivo. È bene notare che chi non si converte in articulo mortis è difficile che si converta in tutto il resto della sua vita. Viceversa per chi si converte in un frangente così critico, il suo atto di sottomissione alla pena giusta acquista un valore espiatorio e meritorio che altrimenti non avrebbe».
Dopo averla accuratamente esaminata, possiamo convincentemente sostenere che si tratti di una posizione anticristiana? Per quanto possano sembrare riprovevoli all’uomo medio di oggi (ed alla maggior parte degli uomini di chiesa), le idee di Tyn sono in pieno accordo con quelle di Alfonso de’ Liguori, con la Tradizione, con la Catechesi, e ancor più con le ‘Scritture’.
Dare la morte, ricevere la morte
Passiamo ad una catechesi di qualche decennio prima. Nelle sue conferenze per la quaresima del 1896, Monsignor D'Holst, di Biarritz, trattava l'argomento della Morale Sociale della Chiesa Cattolica. La terza conferenza affrontava il tema del ‘rispetto della vita umana’:
«L'uomo ha una avversione naturale per la morte […] per la più forte ragione deve odiare la morte violenta […] Ricevere la morte e darla in tal modo son due cose orribili, ripugnanti egualmente alle inclinazioni del nostro essere sensibile. Ma se noi interroghiamo il nostro essere morale, l'eguaglianza scomparisce: la morte subita può essere un guadagno da cui è resa preferibile alla vita: 'mori lucrum', e può rivestire una bellezza che la fa ricercare con passione: 'potius mori quam foedari’. Per l'uomo adunque degno di tal nome, uccidere è cosa peggiore di quello che non sia morire".[6]
D’Holst esecra la vendetta personale come male gravisimo perché
«quando l'uomo fa della morte lo strumento della sua propria vendetta usurpa un diritto del Creatore, ed è un primo delitto, il più grave di tutti, perché attenta alla maestà infinita, si appropria della sua sovranità, altera l'armonia del mondo ed i fini dell'universo».[7]
La ‘vendetta pubblica’, secondo questo teologo, è invece pienamente legittima. Ma questo diritto autorizza a dare la morte al colpevole? Secondo lui si, per quattro ordini di motivi: (a) preservare la società mettendo il colpevole in condizione di non nuocere; (b) ispirare agli altri uomini un salutare timore del castigo; (c) prendere di mira il colpevole aiutandolo a emendarsi per il suo bene; (d) cercare di ristabilire l'equilibrio morale voluto dalla giustizia assoluta. A questo punto, il conferenziere si getta in una critica serrata del pensiero di quanti vorrebbero abolire la pena di morte, ritenendo che soprattutto non valga la ragione dell’ «equilibrio morale» raggiunto tramite una pena espiatoria. Secondo gli oppositori alla pena capitale, il carcere è sufficiente a dissuadere gli uomini dal crimine, e la pena di morte manca nel suo fine principale che sarebbe il miglioramento morale dell'uomo vizioso. Ma per D'Holst, la principale ragione di questo dissenso sta nel fatto decisivo che costoro
«non credono nell'assoluto [e] se la giustizia non ritrova in una origine divina un carattere trascendente, addiviene molto malagevole il distinguere in essa la funzione penale dalla funzione preservatrice».[8]
In molti, sostiene ancora D’Holst, vorrebbero eliminare l'assoluto, ma non si possono eliminare i problemi metafisici, e dunque bisogna
«riguardare la difficoltà in faccia e dimandarsi se la giustizia vendicativa deve limitare la sua parte alla protezione degli innocenti».
Secondo D'Holst, la risposta è no; perché si insiste allora nel volere emendare il colpevole di omicidio?
«Forse perché, ritornato buono, non posa più nuocere agli altri? Ma si renderà egualmente inoffensivo facendolo morire [...] A un misfatto senza paragone è necessario un castigo a parte. E siccome l'ordine ha ricevuto qui il più grave attentato, conviene che la pena sia portata al massimo del suo rigore. Altri colpevoli saranno posti in occasione di emendarsi, per ricominciare quaggiù una vita migliore: questi non dovrà cercare nel pentimento che un porto di sicurezza contro le pene eterne. La Chiesa, che si è sempre ricusata di condannare come abusiva in sé la pena capitale, si è sempre mostrata piena di sollecitudine per l'anima di colui che è destinato da una giusta sentenza all'espiazione suprema. Che questo sventurato accolga le anticipazioni della misericordia infinita: che accetti la sua pena, e si studi di trasformarla in un'immolazione volontaria. Così l'ordine morale da lui alterato col suo delitto, si trova ristabilito col suo sacrifizio. La giustizia raggiunge il suo fine più elevato, ed il potere umano non ha da arrossire da una severità la quale fa di esso il ministro di Dio».[9]
Nella sua apologia della pena di morte, il conferenziere prosegue condannando i sostenitori del libero pensiero, ovvero coloro che non credono alle ‘verità soprannaturali’ ed al libero arbitrio. Costoro vengono dichiarati in errore nel biasimare la pena di morte, per una ragione evidente: la loro tesi è solidale ad un errore concettuale di fondo e dunque appare irrimediabilmente falsa. Alla fine della sua requisitoria, il prelato trova perfino, fra le righe dei “Vangeli”, motivi per scegliere la pena di morte:
«La vera mansuetudine non consiste nel snervare la repressione, cancellando dalla lista delle pene quella che esercita sulle coscienze abituate al delitto l'azione più efficace. Si risparmia un maggior numero di vite umane con un giusto rigore che colla debolezza. Si, perché l'esempio del castigo supremo, prevenendo altri omicidi, preserva altre vittime».
La tendenza moderna di offrire garanzie legali all'accusato, di cercare il più possibile di evitare errori giudiziari, e la possibilità graziare il colpevole sono viste come effetti lontani del “Vangelo”, che purtuttavia non tolgono legittimità alla pena di morte, che comunque va liberata dalle tracce di crudeltà che l'hanno in genere accompagnata, giacché il fare morire un condannato nell'odio e nella disperazione nuocerebbe irreparabilmente alla sua anima. E dunque
«dopo avere concesso questo all'umanità, non lasciamo affermare che la società addiviene assassina, quando colpisce gli assasini. Diciamo piuttosto, diciamo arditamente che essa comprende meglio la sua missione protettrice, ne rialza la dignità, ne accresce le garanzie, unendovi una preoccupazione morale presa dall'idea della giustizia e dalla credenza del libero arbitrio»;[10]
«l'abolizione della pena capitale sarebbe un incoraggiamento al delitto […] la giustizia vendicativa è nella società umana una delegazione del potere divino, proprio come il diritto di comandare di cui è la sanzione».[11]
[1] Cfr.: Bianchi D., L'intero libro di Dio, chiamato Bibbia. Alle origini dell'identità puritana, Cromohs, 8 (2003): 1-18, www.cromohs.unifi.it/8_2003/bianchi.html
[2] La seconda Admonition to Parliament affermava: «La Parola è al di sopra della Chiesa, sicuramente al di sopra della Chiesa inglese». Cfr. W. H. Frere-C. E. Douglas (eds.), Puritan Manifestoes. A Study of the Origin of the Puritan Revolt, London, Society for Promoting Christian Knowledge 1954, p. 92.
[3] www.cromohs.unifi.it/8_2003/bianchi.html#fn14
[4] I Corinti 5, 11.
[5] Questa e le successive citazioni sono tratte da: Tyn T.M, I limiti della vita, pubblicato su www.totustuus.biz/users/tyn/tyn02.htm
[6] Mons. D'Holst, 1938, pp. 57-58.
[7] Mons. D'Holst, 1938, p. 60.
[8] Mons D'Holst, 1938, pp. 68-69.
[9] Mons D'Holst, 1938, pp. 69-71.
[10] Mons D'Holst, 1938, pp. 73-74.
[11] Mons D'Holst, 1939, pp. 336-337.