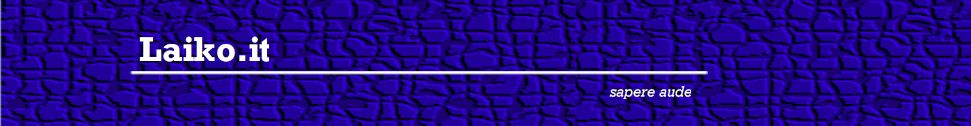Il teatro musicale moderno: lontano da dio, vicino all’uomo.
Il teatro musicale più conosciuto, ovvero il melodramma ottocentesco (che prevale nei palinsesti delle istituzioni musicali, e pressoché l’unico che sporadicamente fa capolino nella TV di stato), aveva pochi saldi riferimenti: patria, Dio, famiglia, onore. Protagonisti e comprimari rappresentavano per lo più chiaramente gli estremi contrapposti: buono e cattivo, eroe e vittima, furbo e stolto, governante e suddito, e così via.
Questo genere, che intendeva soprattutto suscitare emozioni, attrarrebbe poco l’utente moderno con le sue storie abbastanza stereotipate, se l’azione scenica non fosse sopravanzata dalla vitalità dall’elemento musicale. Nell’evoluzione successiva del teatro musicale tutto invece cambia, c’è aria di nuovo; e tanto quanto la musica comincia ad allontanarsi dalla capacità media degli utenti di comprenderla, le vicende rappresentate si avvicinano sempre più alla vita reale: storie di uomini, con la propria variegata soggettività, e non più semplici maschere, come nel teatro antico.
Pur con gli ovvi limiti di tutte le scansioni arbitrarie, seguendo un personale percorso di lettura (più sentimentale che tecnico, e sostanzialmente suggeritomi dalla mia personale discoteca) vorrei indicare l’anno 1900 come momento cruciale di transizione. Freud ha appena pubblicato la sua “Interpretazione dei sogni”, che spalanca gli abissi dell’inconscio, quand’ecco che viene messa in scena la deliziosa (poco conosciuta in Italia) “Louise” di Gustave Charpentier, una delle opere di maggior successo di tutti i tempi. C’è qualcosa in essa che ne fa un documento di particolare importanza: la rappresentazione (sia pure in una cornice sostanzialmente bohemienne, a tratti sdolcinata) di una credibile quotidianità. Un uomo ed una donna si amano, vogliono vivere insieme, ritengono che ogni essere abbia semplicemente diritto alla propria libertà ed alla propria felicità. Le loro scelte non trovano ostacoli nel gioco dei potenti o in un imperscrutabile fato, ma nell’incomprensione dei genitori. Né dramma, insomma, né verismo, ma vita reale. Non eroine immolate nell’ultima scena, ma una donna che banalmente va via di casa lasciando aperto ogni discorso su ciò che potrebbe accadere dopo, come in tanta drammaturgia moderna.
Molti autori del Novecento si rivolgono alla classicità o si rifugiano nel fiabesco, come a sottolineare una sorta di neutralità rispetto al mondo che cambia (sintomatica in tal senso la parabola compositiva di Richard Strauss); qualcuno musica, per sfida intellettuale, la assoluta banalità (è il caso di “Amico Fritz” di Mascagni e di “Intermezzo” di Strauss); altri rappresentano l’ordinario male del vivere. “Jenufa” di Leos Janáček è uno dei primi esempi di opera veramente moderna, in cui l’epica (ad esempio quella wagneriana) cede definitivamente il passo al lato serio dell’esistere: non la morte dell’eroe, dunque, ma l’infanticidio. Hanno toni particolarmente forti la “Lulu” ed il più celebre “Wozzek” di Alban Berg, che ha profondamente influenzato gli autori successivi. E non può sottrarsi ad una sensazione di sgomento lo spettatore del “Castello di Barbablù” di Bela Bartok, esplorazione quasi psicoanalitica di inquietanti stati d’animo.
Ma l’avvicinamento al reale non ne coglie solo i tratti tragici od oscuri; la rappresentazione del quotidiano può servire anche a riflettere sulle disarmonie della società, sulle sue ingiustizie (quelle vere, piuttosto che ad esempio le esternazioni poco più che salottiere di un “Andrea Chenier”). Ad un abbastanza retorico Umberto Giordano ecco dunque contrapporsi i moniti del teatro brechtiano musicato da Kurt Weill: “Opera da tre soldi”, e “Mahagonny”. Questo autore tedesco, presto rifugiatosi negli Stati Uniti, quando non più condizionato dall’urgenza di un messaggio politico, ha prodotto un’altra ispirata opera, quel “Scene di strada” che porta ancora alla ribalta (come già il “Porgy and Bess” di Gorge Gershwin) la vita problematica di una periferia urbana, con il suo disordine, con il suo marciume, ma anche con i suoi sogni; in definitiva, con la sua partecipata umanità. Così sulla scena non campeggiano gli slanci crepuscolari di una sartina per il poeta, ma il desiderio di una donna frustrata che sente di volere vivere nonostante tutto, che spera di evadere dal soffocante grigiore domestico, quand’anche il suo principe azzurro fosse un gelataio; sullo sfondo, non arie guerresche o cerimoniali, ma uno sfratto.
Nel teatro musicale moderno, i richiami alla realtà tendono comunque a sovrastare l’elemento fantastico. Talora l’effetto è quasi surreale, ma non per questo improbabile, come nella splendida “Ora spagnola” in cui Maurice Ravel racconta, con assoluto disincanto, la vicenda comica di amanti tanto raffinati quanto pasticcioni, beffati nel loro assedio alla bella di turno da un semplice mulattiere. Al di là di questi momenti giocosi, non si propongono generalmente emozioni fuggevoli, da dimenticare presto, né una catarsi finale: morte od apoteosi dell’eroe (e più spesso, dell’eroina). Lo spettatore è piuttosto invitato a partecipare direttamente a quanto si svolge sul palcoscenico, come se potesse accadere a lui stesso; gli si chiede un parere, di tornare a casa con un tema esistenziale da sviluppare e risolvere.
Torniamo indietro nel tempo: chi può pensare plausibili le vicende del mozartiano “Ratto del serraglio”, della rossiniana “Italiana in Algeri”, o delle altre innumerevoli opere che pure sembrano parlare di conflitti (nel caso specifico, fra Occidente e mondo arabo), di congiure, di tradimenti. In questi casi una certa ‘cattiveria’ dei personaggi, la stessa diversità delle posizioni a confronto e la varietà dei ritratti umani sono un semplice pretesto per equivoci e sberleffi, per mostrare con ironia il lato leggero della vita; non c’è ancora, se non nei pur coraggiosi limiti delle mozartiane “Nozze di Figaro” una vera analisi sociale. Il pubblico vuole divertirsi, pensando quasi solo per gioco a cosa sarebbe il mondo senza i potenti e le loro angherie. Lo spettatore può tranquillamente distrarsi fra una scena e l’altra, anche perché sa bene che è nei recitativi che si sviluppa la vicenda, mentre le arie sono per lo più di genere, buone indifferentemente per qualsiasi opera e magari già ascoltate.
Ma provi lo spettatore a distrarsi di fronte a “Un posto quieto” o al più noto “West side story”, entrambi di Leonard Bernstein, paradigmi di un teatro fortemente umanista. Ancora una volta, sul palcoscenico si muovono uomini e donne reali, impegnati in una vicenda che riflette saldamente la cronaca. È ben nota la trama di “West side story”, che attualizza il “Romeo e Giulietta” shakespeariano, mentre in pochi conosceranno quella di “Un posto quieto”: dopo la improvvisa morte di una donna, il marito legge i suoi diari e ripercorre sotto una nuova luce, fra rimpianti e pentimenti, la storia del suo infelice matrimonio, chiedendosi perchè sia andato così e non diversamente. La vera forza dello spettacolo è il suo lato propositivo: il protagonista esorta i suoi figli, in perenne contrasto fra di loro e solo occasionalmente riunitisi per il funerale, ad affrontare concretamente i problemi della loro relazione, aprendosi alla vita come facevano nei loro giochi infantili.
In questo teatro moderno prevale ovviamente l’introversione. Certamente in tal senso sembrava già orientarsi Richard Wagner (vedi l’intenso dialogo fra Wotan e Brunhilde nella “Walkiria”), ma la piena rappresentazione di un’esplorazione profonda della coscienza compare solo nel tardo Ottocento, ed ha il suo chiaro modello nel “Pelléas e Mélisande” di Debussy, cui idealmente si rifà lo psicologismo di molti autori successivi.
Mi si chiederà a questo punto: che c’entra Dio o l’ateismo con tutto questo? Il fatto rilevante è che, come in tanti altri campi della cultura, anche qui Dio (o il ‘sacro’) sembra essersi eclissato. Quante volte Dio è stato tirato in gioco su di un palcoscenico? Pensiamo ai tragici finali di “Rigoletto”, o di “Otello” di Verdi. Od anche, incidentalmente, all’ipocrita professione di fede di Scarpia, nella pucciniana “Tosca”. Un Dio, o degli Dei sempre presenti, talora alla ribalta, talaltra sullo sfondo, come la luna verso cui canta la belliniana “Norma”, o verso i quali si volge con raccapriccio la spontiniana “Vestale”.
Nel Novecento, nessuno attende da Dio giustizia o vendetta, o si offre ritualmente come martire (vedi Gilda, in “Rigoletto”). I personaggi più autentici si muovono come se Dio non ci fosse. Wozzeck non chiede alla sua donna di recitare le preghiere prima di ucciderla, come invece fa Otello. Ogni morte è tragicamente umana, come quella della straussiana Salomè. E nessun intervento prodigioso orienta gli esiti.
Il Dio cristiano, se vogliamo andare nello specifico, è al massimo una coloritura di fondo; né valgono le “Carmelitane” di Francis Puolenc o la “Suor Angelica” di Giacomo Puccini a dare spessore alla rappresentazione della religiosità.
Piuttosto, nel teatro moderno, tiene banco il diavolo, dal poco convincente “Belfagor” respighiano allo stravinskiano Nick Shadow (“La carriera di un libertino”); diavolo di ben altra caratura; mentore e corda stonata della coscienza dello stolto protagonista più che presenza teologicamente credibile. Per cui a molti melomani riesce meglio comprensibile il più teatrale ottocentesco “Mefistofele” di Arrigo Boito, facilmente sopraffatto da un improbabilmente redento Faust in uno scontato finale.
Cos’è cambiato, in questo teatro moderno, rispetto ad un passato, che tutti consideriamo ‘classico’, con tutte le sue sovrastrutture, in gran parte religiose? Chi può non estasiarsi, di fronte ad autentici monumenti musicali quali la “Passione secondo Matteo”, di Johan Sebastian Bach, perfetta integrazione fra musica e testo, fra cornice e significato, vertice assoluto del Barocco, in cui la musica si dimostra modalità espressiva privilegiata per rappresentare l’anelito al divino, sia pure entro i limiti della testualità biblica. In essa è ben chiara l’adesione entusiasta del compositore (vero e proprio strumento di Dio) al significato di ciò che viene musicato, al di là delle regole e degli obblighi della committenza.
All’approssimarsi della modernità l’ambito religioso si trasforma in mera occasione per il confezionamento di prodotti che di sacro mantengono il testo ma non la musicalità; vedi l’esempio dello “Stabat Mater” di Pergolesi, il cui virtuosismo vocale e strumentale adombra la drammaticità del testo; ma si potrebbe anche tornare indietro alla vivaldiana coloritissima “Juditha triumphans”.
Gradualmente la distinzione fra sacro e profano sfuma. Prendiamo ad esempio il caso della “Creazione” di Haydn, specie nelle sue iniziali complesse disarmonie o del ricco tessuto musicale del “Christus” di Liszt, che ben si ascoltano al di fuori di qualunque contesto religioso. Il testo che supporta l’opera di Haydn appare ai nostri tempi quasi puerile, all’opposto di quelli musicati da Bach nelle sue passioni.
Il Novecento non ha saputo proporci pressoché nulla di altrettanto valido, con intento dichiaratamente edificante in senso religioso. La teologia viene evitata anche nelle citazioni occasionali. Il sacro sopravvive solo come dimensione privata, come intima riflessione sull’esistere. Ne sono chiari precursori i versi deisti ed i suoi laici della “Nona Sinfonia” beethoveniana e gli angosciati accenti dello shumaniano “Il paradiso e la Peri”. Per i compositori del Novecento, religiosità non vuol dire più religione; ogni discorso su Dio è pensiero inesprimibile, come nel “Mosè e Aronne” di Arnold Shoenberg, che resta infatti opera incompleta ed incompiuta.